La grande risorsa dei vitigni autoctoni minori della Sicilia
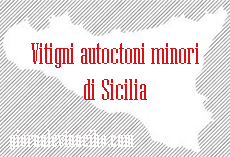 di Vincenzo Bonomo
di Vincenzo Bonomo
La viticoltura e l’enologia costituiscono per molti Paesi una realtà economica e sociale di notevole importanza; la progressiva introduzione della coltivazione della vite ha segnato per molte aree l’inizio di una civiltà che attraverso la cura dei vigneti e la nascita poi del vino ha espresso la tradizione culturale e storica di un popolo. In Sicilia il lungo cammino della coltivazione della vite passa attraverso una realtà costellata di numerosi vitigni, oggi le aziende operano a fronte dell’esigenza di adeguarsi alle innovazioni proposte dalla ricerca scientifica e tecnologica ma anche imposte dall’evoluzione dei mercati e da una domanda sempre crescente di vini pregiati legati al territorio d’origne.
L’azione di selezione e di recupero dei vitigni autoctoni ha orientato i produttori siciliani verso l’adozione di scelte varietali oculate e strategiche che potessero valorizzare le produzioni. La valorizzazione della piattaforma ampelografica rappresenta uno dei principali punti di forza per il potenziamento della viticoltura di ciascuna regione italiana. Intorno agli anni ’90 in Sicilia si è puntato sulla diffusione di vitigni internazionali soprattutto a bacca rosa, quali il Cabernet Sauvignon, il Merlot e il Syrah, con il fine di produrre vini monovarietali (come previsto anche in alcune nuove Doc) o da utilizzare in miscela con alcuni vitigni autoctoni.
Negli ultimi anni si è preso coscienza dell’elevata potenzialità vitivinicola dei vitigni autoctoni, che rappresentano peraltro uno degli strumenti principali per la tipicizzazione e la differenziazione delle produzioni enologiche. I vitigni autoctoni siciliani sono caratterizzati da un’elevata variabilità, sottoposti negli anni a selezione massale da parte dei viticoltori, i quali ancora oggi selezionano e moltiplicano gli individui ritenuti migliori, ricorrendo all’innesto a dimora delle barbatelle selvatiche.
I vitigni autoctoni siciliani più diffusi e quindi conosciuti sono il Catarratto, il Nero d’Avola, il Grillo, l’Insolia ed il Nerello Mascalese, di altri si parla un po’ meno, ecco, quindi, qualche nota sui alcuni vitigni autoctoni sicilia minori che rappresentato certamente un’importante nota di differenziazione nella produzione enologica isolana :
Carricante
Il Carricante, in dialetto «‘U Carricanti», è un antichissimo vitigno autoctono dell’Etna. Fino agli anni ’50 era il vitigno ad uva bianca più diffuso nella provincia di Catania di cui occupava il 10% della superficie vitata. Intorno al 1885 fu introdotto nelle campagne di Agrigento e di Caltanissetta, non trovando, però, adeguata diffusione. È stato selezionato dai viticoltori di Viagrande che gli hanno attribuito questo nome per sottolineare l’attitudine del vitigno a dare una buona produzione costante negli anni. Da sempre coltivato alle falde del vulcano sul suo versante est, solitamente nelle contrade più elevate dove il Nerello Mascalese difficilmente maturava o nei vigneti più bassi insieme allo stesso Nerello Mascalese e con la Minnella bianca.
Damaschino
Il suo nome farebbe pensare ad un’origine araba nel territorio di Damasco, ma non si dispongono notizie certe. Nel Bollettino ampelografico del 1883 troviamo una ‘Damascena bianca’ tra le cultivar presenti nella provincia di Palermo, ma secondo Bruno Pastena non si tratterebbe del medesimo vitigno. Lo troviamo invece nella descrizione dei vitigni coltivati nella provincia di Caltanissetta, dove, però è riportata come cultivar di minore importanza. A inizio del XX secolo si diffonde nella zona di Marsala (TP), per poi subire negli anni ’30 una forte contrazione a favore del Catarratto.
Grecanico
Il Grecanico fa parte di una vasta popolazione di vitigni introdotta dalla Grecia, l’Abate G. Geremia nella sua “Stafulegrafia” del 1835 descrive per l’agro di Randazzo un “Grecanico a giriamoli” tendente più o meno alla colatura ed acinellatura. Nella viticoltura prefillosserica il vitigno era noto nelle province di Trapani, Catania, Caltanissetta, ma si è diffuso maggiormente in quella di Trapani. Oggi il Grecanico è caratterizzato da due cloni, uno a grappolo spargolo, diffuso nel trapanese ed un altro a grappolo serrato, meno diffuso e presente in prevalenza nella Sicilia occidentale.
Minnella
Girando per i vigneti dell’Etna è facile trovare un vitigno a bacca bianca dal grappolo medio-grande e con il caratteristico acino dalla forma allungata: il Minnella (in dialetto «Minnedda» o «Minnedda Janca» dove Janca sta per bianca). Questo vitigno autoctono fu scoperto nelle vigne più antiche dell’Etna. Sulle sue origini, però, non si hanno notizie storiche. Il suo nome deriva dalla parola «minna», termine dialettale che indica la mammella, per la forma oblunga dell’acino molto simile ad un seno di donna. La Minnella è allevata ad alberello ed è generalmente associata al Nerello Mascalese e/o al Carricante. Si coltiva alle falde dell’Etna, sul suo versante Est, e precisamente nella zona del Monte Serra, il cono vulcanico alla quota più bassa (500 metri s.l.m.), che ricade nel territorio del comune di Viagrande.
Nerello Cappuccio
Non si conoscono le origini di questo vitigno che da sempre è stato allevato nei vigneti etnei insieme al Nerello Mascalese anche se in percentuali decisamente inferiori (15-20% della superficie vitata). Il «Nerello Cappuccio» o «Mantellato», detto in siciliano «Niurieddo Anmmantiddatu» o solo «Mantiddatu» deve il suo nome al singolare portamento della pianta (a cappuccio, a mantello). Il vitigno è coltivato ad alberello.
Nocera
Il vitigno Nocera è ampelograficamente molto affine ai Nerelli. Viene coltivato tradizionalmente in Sicilia nell’area del messinese da tempi molto antichi. Alcuni fanno l’ipotesi che sia legato agli storici vini “Mamertinum” e ai vini di “Zancle” celebrati dagli antichi latini. Un tempo diffusissimo, nei vigneti in provincia di Messina si possono trovare ceppi molto antichi, anche se oggi è ridotto a pochi ettari, soppiantato, oltre che dai vitigni etnei Nerello Mascalese e Cappuccio, da vitigni nazionali ed internazionali. Piante sparse sono presenti anche nei vigneti in provincia di Catania, Siracusa e Ragusa. Il Nocera entra a far parte, con il Nerello Mascalese e Cappuccio, nel disciplinare di produzione della Faro Doc. Questo vitigno è stato anche “esportato” in Calabria con un certo successo e, a metà del secolo scorso, in Francia: Provenza e Beaujolais, la patria del novello, dove si è diffuso con i nomi di “Suquet” e “Barbe du Sultan”.
Perricone
Questo vitigno d’antica coltivazione, a fine ‘800 era il vitigno a bacca nera più diffuso nelle province di Palermo e Trapani, ma lo si trovava ampiamente coltivato anche nelle zone di Caltanissetta e Agrigento. Nella prima metà del ‘900 subisce una forte contrazione prima nella provincia di Trapani e successivamente in quella di Palermo. Il sinonimo Pignatello sembra derivare dalle “pignatidare”, le terre rosse alluminose del Trapanese, così chiamate perché impiegate per la fabbricazione delle pignatte da cucina, particolarmente vocate per la coltivazione di questa varietà.
In conclusione, ben si vede come la Sicilia abbia trovato nella rivalutazione e nella riscoperta degli antichi vitigni autoctoni quel forte legame con il territorio che caratterizza le più recenti produzioni vinicole avendo così il duplice risultato di scongiurare la loro scomparsa e di produrre vini con note varietali differenti e particolari.













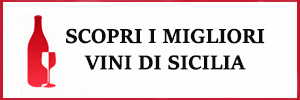








Leggere e’ come andare a scuola.Ho proprio azzeccato a mettermi in contatto con voi.
Grazie per aver inserito la Minella, è atutti sconosciuta ma da noi sull’Etna è coltivata da sempre da mio nonno e dai miei avi, la mischiavano ai nerelli, allora non si distinquevano e vinificavano le uve seoaratamente, fa parte della noastra storia
complimenti è veramente un bell’articolo, esposto con linguaggio semplice adatto anche ai non addetti ai lavori, di solito usano questo genere di linguaggio le persone che hanno un alta preparazione professionale, perchè la loro cultura li porta ha esprimere i concetti con un linguaggio accessibile a chiunque proprio per essere chiari nell’esposizione. Bravo!
. Ho scoperto cose che non conoscevo minimamente